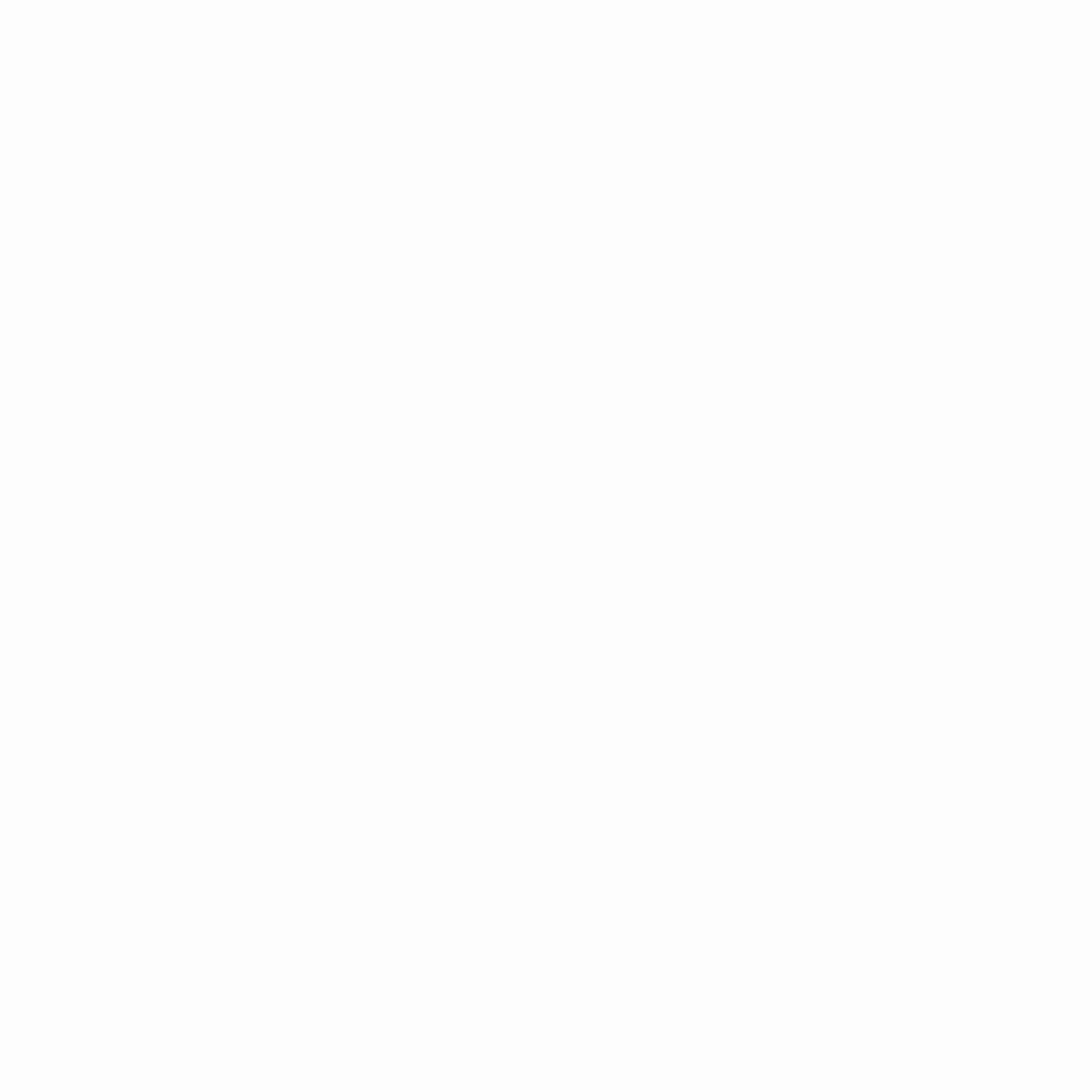IL COSTRUTTORE DI LAMPADE
di Edoardo Zunica
Mio zio, all’anagrafe Emilio Ischitano, era un tipo avventuroso e aveva da poco compiuto trent’anni. In quella torrida estate degli anni 70, come tutte le estati, stava trascorrendo buona parte delle sue vacanze da solo. Proprio in quei giorni accadde un evento che gli avrebbe cambiato la vita.
Oltre ad essere un uomo avventuroso, era un tipo solitario. Il classico soggetto che molti definirebbero un lupo di mare; solo che, anziché andare per mare, a lui piaceva andare per spiagge. Ma non quel genere di spiaggia dove i bagnanti si accalcano alla disperata ricerca di un fazzoletto di terra dentro cui incastrare il proprio asciugamano, tra un bambino che frigna e un anziano che ronfa, la pancia gonfia come un cocomero maturo. Non che in Calabria, sulla costa Tirrenica, negli anni 70, fosse così frequente incontrare bagnanti di questo genere. Mio zio, però, non ne voleva vedere neanche uno. A lui piacevano le spiagge deserte, desolate, selvatiche. Se un po’ deturpate (ma non troppo), tanto meglio.
Un giorno aveva optato per un’escursione in una caletta che si poteva raggiungere solo calandosi da una scogliera a mani nude. Di raggiungere spiagge a piedi, negli ultimi tempi, non se ne parlava proprio. Più il sentiero si faceva impervio al passaggio dell’uomo, meglio era per Emilio Ischitano. Figurarsi che considerazione poteva avere delle persone che le spiagge le raggiungevano con i loro yacht privati.
Io li schifo, quelli!, sosteneva sdegnato ogni volta che ne vedeva uno. E ancora: Puh!, era il verso che emetteva poco dopo aver generato un grumo di catarro, che con eleganza britannica scagliava il più lontano possibile mentre, puntualmente, un rivolo di quello stesso catarro gli rimaneva attaccato alle labbra e gli colava fino al mento rasato finché, tempestivo, non interveniva con le dita a pulirsi.
Quel pomeriggio, l’afa mediterranea era in forma smagliante: si manifestava nella sua versione più umida e appiccicosa e rendeva la sabbia rovente come il cuore di un vulcano. Il sole, nel frattempo, incombeva austero sopra ogni cosa. Dire che la giornata fosse invivibile, sarebbe un blando eufemismo.
Ciononostante, mio zio stava bene. Altro che se stava bene! Non solo il caldo non gli dava fastidio, ma Emilio, in quell’arsura così pungente, riusciva persino a raggiungere un placido stato di nirvana che poche altre cose erano in grado di assicurargli nella vita. Sembrava che più le condizioni climatiche imponevano una sfida di sopravvivenza, più lui ci prendeva gusto.
Ad ogni modo, persino lui aveva bisogno di tuffarsi in mare. Non tanto per refrigerarsi; quanto, piuttosto, per un viscerale bisogno di entrare in simbiosi con l’acqua salata. Ne aveva bisogno e gli piaceva da matti.
Adorava fare snorkeling, e come un rapace marino nuotava per ore a fior d’acqua, pronto a scagliarsi in giù per pescare un polpo a mani nude o recuperare conchiglie e altri tesori adagiati sui fondali.
E fu così che quel giorno, sul letto del mare, scorse un oggetto insolito.
Quella cosa, per quanto indefinita e all’apparenza banale, emanava fascino. Sarebbe scorretto etichettare quel fascino come irresistibile, non sapendo Emilio nemmeno di cosa si trattasse. Per questo, non ci spingeremo così in là, ma non avremo problemi a definirlo, quantomeno, magnetico.
Emilio Ischitano prese fiato e si immerse: la sua sagoma, elegante e affusolata, scivolò nel blu. Nuotò per una decina di metri, afferrò il relitto e con il poco fiato residuo rimastogli nei polmoni lo riportò in superficie: si trattava di una curiosa lastra irregolare, composta di un materiale difficile da identificare. La lastra, spessa tre o quattro dita, aveva il colore e le venature della pietra, ma alla vista le sue irregolarità, ricordavano quelle di un pezzo di legno.
Dopo averla portata in spiaggia, le diede il tempo di asciugarsi, in modo da agevolarne l’ispezione in un secondo momento. Così fece, e l’investigazione produsse il seguente verdetto: stu cosu è proprio nu cazz’i piezz’i lignu!
Un legno piuttosto bizzarro, però, dal momento che, anziché galleggiare, giaceva sul fondale, nemmeno fosse piombo della seconda guerra mondiale.
Proviamo, si disse Emilio risoluto. E così, senza pensarci troppo, scagliò l’oggetto in mare, vicino alla riva, per osservarne il comportamento a contatto con l’acqua.
Cosa cazzo mi è saltato in mente!, pensò non appena lo vide sprofondare.
Rapido, si precipitò a salvare la lastra con affanno. Una volta riportatala a riva, rimase in sua contemplazione per almeno un paio di minuti, solo il rumore del suo respiro pesante e il leggero infrangersi dell’acqua sul bagnasciuga spezzavano il silenzio di quel pomeriggio.
Emilio inorridì al solo pensiero della becera fine che l’oggetto avrebbe potuto fare se fosse rimasto lì da solo, in balia degli eventi.
Qualsiasi cosa fosse, quella lastra aveva in sé qualcosa di indispensabile. All’epoca, Emilio Ischitano non era ancora in grado di capire cosa fosse; forse non lo avrebbe mai capito fino in fondo.
Nei giorni seguenti, incuriosito dall’accaduto e soprattutto dalla natura del materiale di quel relitto, mio zio chiese a un suo amico archeologo di ispezionare l’oggetto. Non accennò, però, al dettaglio del galleggiamento, reputandola un’informazione troppo riservata da condividere con altri.
Dalle indagini dell’amico non solo emerse che si trattava, proprio come aveva ipotizzato lui, di un pezzo di legno; ma anche che quel pezzo di legno era appartenuto, con ogni probabilità, a una nave del Seicento affondata da quelle parti. È molto difficile rendere a parole la sensazione di esclusività che gli si diffuse dentro, colonizzando ogni centimetro della sua anima.
Per lunghi anni mio zio nascose il relitto all’interno di una baule di cui nessuno fu mai a conoscenza. Alla sola idea che altri potessero toccare o, addirittura, guardare il suo gioiello senza il suo consenso, inorridiva. Un brivido di disgusto gli attraversava tutta la spina dorsale fino a punzecchiargli il cervelletto con delle fastidiosissime scossette elettriche. Era un oggetto di antiquariato e come tale andava trattato. Non andava profanato. Solo ogni tanto apriva il baule e si concedeva qualche secondo di contemplazione. Poi, immediatamente, chiudeva tutto.
Per anni il pezzo rimase lì e mio zio non ci fece nulla.
Più avanti, tuttavia, cambiò idea.
Dopo la pensione, Emilio Ischitano crollò in un profondo stato di depressione. Aveva un’enormità di tempo libero, senza avere la più pallida idea di come occuparlo. Questo gli procurava un forte disagio, un senso di smarrimento e inappartenenza alla sua stessa vita che non sapeva come risolvere.
Grazie al cielo, era sempre stato un uomo con uno forte senso della manualità e uno spiccato spirito creativo, così si inventò un passatempo tutto suo: iniziò a costruire lampade.
Se ne andava al mercato delle pulci a scegliere i pezzi. Acquistava oggetti di antiquariato e li assemblava ricavandone lampade dalle forme più stravaganti e contorte. Lavorava notte e giorno, tant’è che riuscì anche a trasformare il passatempo in un mestiere. Amici e parenti gli commissionavano lampade, che poi rivendeva a prezzi insignificanti, per nulla proporzionati alla loro bellezza e alle ore di lavoro spese.
Dei soldi nun minni frica nu cazzu, ripeteva ogni volta che qualcuno gli ricordava il valore dei suoi manufatti. Le costruirei comunque, anche se nessuno se le volesse pigliare.
Nel giro di qualche anno, la sua popolarità di artigiano di lampade crebbe, e con questa i clienti – spesso anche prestigiosi – che sempre più acquistavano le sue opere a prezzi ridicoli.
Un’estate capitai nella sua villa in Calabria insieme alla mia ragazza. Entusiasta della nostra presenza, mio zio iniziò a mostrarci le sue creature con orgoglio.
Questa è una lampada che ho costruito mettendo insieme pezzi di un antico lampadario. Vedete? le due estremità sono speculari. Rappresentano l’eterna lotta di (di chissà quale lotta si
era immaginato sotto effetto di chissà quante canne, pensai). Questa invece la vedete? Un tubo di vetro pieno di biglie, si protende verso l’alto. Rappresenta la tensione verso la divinità. Quest’altra cambia colore ogni 3 secondi passando per tutte le tonalità dell’arcobaleno. E così via con un altra decina di lampade, di fronte ai nostri occhi affascinati.
Lampada dopo lampada, la curiosità cresceva. Improvvisamente, Emilio Ischitano si bloccò. Rimase in silenzio per qualche secondo. Poi, col tono di chi ha smesso di parlare di faccende terrene ed è approdato nel territorio dell’ultraterreno, riprese: vabbè, ma se vi faccio vedere quella che ho nella stanza al piano di sopra… Non vi potete manco immaginare la storia che c’è dietro.
Salimmo le scale dell’antica casa, ed entrammo nella stanza. In un angolo, nascosto dagli sguardi indiscreti di chiunque fosse capitato lì dentro, giaceva indisturbato uno strano oggetto. La luce del lampione, penetrando dalla finestra, lo avvolgeva con un flebile fascio giallo, illuminandone solo i contorni irregolari.
Quando mio zio accese la luce generale della stanza, ci trovammo di fronte a una creatura inanimata che sprigionava un fascino solenne e insieme sinistro; elegante e, al medesimo tempo, sospetto; consumata dai secoli e contemporaneamente in grado di diffondere un’aura di eternità. Si trattava di una lastra irregolare incastrata su un piccolo piedistallo di marmo e decorata con gingilli dalle forme più varie.
Di che materiale è fatta secondo voi? Ci interrogò immediatamente mio zio, con l’ironico autocompiacimento di chi la sa lunga.
Pietra, rispondemmo con certezza. Del resto, l’oggetto, solido e compatto alla vista, aveva dei riflessi opachi simili a quelli del marmo grezzo. Al contempo, però, era scuro e quindi non si capiva bene di cosa fosse fatto. Ad ogni modo, sono pronto a giurare che chiunque, senza incertezze, avrebbe detto pietra.
No, cari miei. Questo è legno, ci rispose, soddisfatto per averci tratto in inganno come pianificato dalla sua domanda.
E così ci raccontò dell’insolito ritrovamento della lastra di legno in fondo al mare avvenuto quell’estate di tanti anni prima. Dopodiché, stimolato ancora una volta dal nostro atteggiamento curioso, attaccò con la spiegazione dettagliata di come a un certo punto aveva deciso di trasformarlo.
Per anni l’ho lasciato in una cassettiera. L’ho trattato come fosse la cosa più preziosa, ma senza sapere che farne. Sapevo che prima o poi gli avrei dato vita, era solo una questione di tempo. Un giorno l’ho tirato fuori dal suo nascondiglio e ho iniziato ad accarezzarlo facendolo scorrere tra le mani e le braccia. Poi ho pensato al mare, il suo luogo d’origine. Quindi, su una delle due facce ho attaccato una ampolla di vetro, turchese come il fondale in cui l’ho trovato. Dopodiché mi sono detto che senza la luce del sole non avrei trovato proprio un bel niente. Quindi, sull’altra faccia ho attaccato questa lampadina.
Lo interruppi: zio, la lampadina sta dentro una tromba? Sembra una tromba in miniatura.
Esatto, rispose mio zio soddisfatto per l’interesse, è una piccola trombetta che avevo acquistato anni fa. Così la sua luce può illuminare il legno come una melodia. Come vedete, però, non illumina solo il legno.
Infatti, risposi. Cosa sono queste? Indicando dei gruppi di sfere d’avorio aggrappati alla lastra che si trovavano proprio nella direzione della luce, in quel momento spenta.
Perle. Rispose Emilio. Senza un corpo pulsante di desiderio non l’avrei mai vista sul fondale e non sarei mai andato fin giù per prendermela. Mi piace pensare che le perle siano la vita. Ne avevo in abbondanza, quindi anche sull’altro lato ho trovato il modo di incastrarle, illuminandole con quest’altra lampadina. Disse così, indicando la seconda luce incorporata nel manufatto.
Rimanemmo un attimo in silenzio a contemplare la bellezza della creatura che avevamo di fronte. Un sistema di cavi neri connessi alle lampadine bucava il legno e con un effetto a spirale enfatizzava il senso di sinuosità del manufatto.
E questa a quanto la vendi?
Questa non è in vendita, rispose mio zio molto serio. Questa lo sai quanto cazzo vale? Mi domandò come se improvvisamente fossi diventato uno spregiudicato avvoltoio pronto a sottrargliela da un momento all’altro. Questa vale nu sacc’i sordi. Ma non me ne frega un cazzo di guadagnarci. Questa rimane qui.
Scusami, risposi. Non volevo urtare la tua sensibilità. Capisco che tu non voglia venderla. Ci sta.
No hai ragione, scusa. Mi sono un po’ agitato. E’ che ci tengo moltissimo. Un anno fa è passato di qui un musicista di Napoli. Un amico di amici. Ha trascorso qui un paio di settimane e quando ha scoperto che costruivo lampade, se ne è innamorato. Me ne ha comprate tre o quattro. Ho provato a regalargliene almeno una, ma non ne ha voluto sapere. Era così affascinato dai miei lavori che li ha voluto pagare fior di quattrini.
Questo è quello che si meritano, diceva. Non un euro di meno.
Io mi sono sentito parecchio a disagio, ma non c’è stato niente da fare.
Poi, una sera, per caso, ha visto lei, disse mio zio indicando la lampada che fino a poco prima avevamo ammirato. Ha fatto di tutto per comprarla. E’ arrivato ad offrirmi cifre spropositate – altro che TFR. Per un attimo io c’ho anche pensato. Ma poi mi son detto: sono vecchio, che cazzo ci devo fare con tutti questi soldi? La lampada vale molto di più. Preferisco tenermela.
Insomma, continuai io, non c’è stato niente da fare per il musicista napoletano. Se ne è tornato a casa con la coda fra le gambe.
Esatto, proprio così rispose mio zio.
Poi rimase in silenzio e per un interminabile minuto spostò il suo sguardo da noi alla creatura che con tanta meticolosità aveva portato alla luce. Fu come se noi non fossimo più all’interno stanza. Guardava intensamente l’oggetto. Nei suoi occhi non c’era solo soddisfazione. Ne era rapito, catturato, intrappolato. Quasi come se non fosse lui ad avere il controllo su di lei, ma al contrario fosse la creatura da lui stesso generata ad avere un’influenza su di lui.
Zio!, gli dissi, risvegliandolo dallo stato di trance in cui era piombato. Posso chiederti una cosa? Dimmi, rispose lui con aria diffidente.
Ce la fai vedere accesa?
Ci guardò intensamente, come per capire, attraverso i nostri occhi, se la richiesta fosse seria oppure no. Il suo sguardo si adombrava sempre di più. Gli occhi a fessura. Le labbra protese in un grugno guerresco. Temetti una reazione brusca, forse violenta. Poi, come per magia, tornò in sé.
E’ tanto tempo che non l’accendo, tagliò corto. Non ho lo spinotto, e poi è tardi. Meglio andare a letto. Dopo aver chiuso a chiave la porta della stanza, si avviò precipitoso al piano di sotto. Poi, ai limiti della cordialità formale, annunciò: mi vado a coricare, a domani.
I giorni seguenti mio zio riprese ad essere gentile e ospitale come al solito, ma non accennò più alla lampada. Le poche volte che provai a parlargliene, si mostrò evasivo. Così, dopo qualche tentativo, decisi di non insistere. Poi partimmo e di quella lampada, direttamente da lui, non seppi più nulla.
Ciò che successe dopo, mi fa rabbrividire ogni volta che ci penso.
Nel corso degli anni seguenti, Emilio Ischitano diventò sempre più intrattabile. Soprattutto dopo un avvenimento che all’apparenza nessuno reputerebbe mai significativo. Un giorno, un gatto gli aveva inavvertitamente urtato la sua lampada prediletta, facendogliela cadere. La lampada non si era fatta un graffio. Eppure, dal quel giorno, Emilio, preoccupato che altri animali o, peggio!, persone potessero mettere a repentaglio l’incolumità della sua creatura, aveva deciso di ritirarsi in casa, riducendo le uscite alle questioni strettamente indispensabili per la sopravvivenza.
Ai vicini di fronte capitava di osservare dalla finestra il comportamento di Emilio Ischitano.
Hai visto? disse una volta Susanna a suo marito Fernando. Lo sta facendo anche stasera.
Che cosa?
Guarda: si mette seduto e fissa dritto di fronte a sé. Per ore non scolla lo sguardo. E poi guarda come sta, tutto dritto, tutto rigido, sembra che abbia un fantasma negli occhi.
Che soggetto, come sta invecchiando male. Chissà cosa minchia guarda tutto il tempo.
Susanna e Fernando non potevano immaginare quale fosse la destinazione dello sguardo di Emilio. Ciononostante, arrivati a questo punto della storia, non sarà difficile tirare a indovinare per il lettore.
Arrivò il punto in cui Emilio Ischitano decise che vivere in quel piccolo paesino era diventato troppo pericoloso. Troppa gente. Basta, si era detto un giorno. Me ne vado via. E fu facile decidere dove.
Ormai settantenne mio zio si spostò in una piccola casetta in cima a una scogliera sul Tirreno calabro che aveva ereditato da un lontano parente. Quel posto, nonostante un’indiscutibile bellezza paesaggistica, era vuoto da almeno mezzo secolo. La polvere e le erbacce selvatiche avevano colonizzato ogni angolo della casa. Cionondimeno, Emilio Ischitano si disse: è il posto perfetto, lontano da tutti. Nessuno che ti rompe i coglioni. E fu così che Emilio abbandonò per sempre la casa in cui aveva vissuto per anni.
Finalmente ti porto al sicuro, sussurrava alla lampada, accarezzandola con delicatezza. Finalmente ti posso guardare senza gli occhi addosso di quei due cretini che ci spiano tutte le sere.
Nonostante la sua veneranda età e lo stato di invivibilità della casa, mio zio riuscì a sistemare la dimora in modo che diventasse per lo meno decente.
Un giorno non resistette più a quella tentazione insistente che per anni aveva covato in silenzio. Non ce la faceva più. Prima di morire, almeno una volta, lo doveva fare.
Adagiò la creatura sul tavolo, srotolò con cura il cavo elettrico generale e lo attaccò alla presa stando ben attento a non inciamparci dentro.
L’effetto fu celestiale. Una luce folgorante inondò di perfezione ogni angolo della casa e, liquida, si sciolse nei suoi occhi colmi di stupore e incapaci di sbattere le palpebre per paura di perdersi lo spettacolo. La bellezza fu così intensa da diventare insostenibile, tanto che Emilio fu costretto a staccare la presa.
Nella vita, ci sono dei momenti in cui la forza irrazionale della creatività umana prende il sopravvento su tutto. Ogni frammento di razionalità viene spazzato via con l’effetto di monsone sulle ultime briciole di pane rimaste sul tavolo quando ormai le posate e piatti sono già stati tolti. In quei momenti non si pensa. E, per giunta, si agisce male. Frettolosamente. Senza curarsi delle conseguenze catastrofiche che i nostri gesti grossolani possono avere.
Questo fu quello che successe ad Emilio Ischitano. Nell’atto di staccare la spina non pose la cura che aveva posto nell’atto di attaccarla. Le sue gambe, tremanti e maldestre, inciamparono sul cavo della sua creatura meravigliosa, che, con la stessa facilità con cui era stata appoggiata sul tavolo, cadde in terra.
Furono attimi interminabili. Mio zio vide tutta la vita trascorsa con lei – ovvero l’unica vita che per lui contava – scorrergli davanti. Mentre la lampada, lenta e solenne, precipitava sul pavimento, Emilio, ancora più lento, si tuffava per terra nel vano tentativo di salvarla tra le braccia.
Non ci fu nulla da fare. La lampada cadde e come un antico vaso in terra cotta, si ruppe in centinaia di frammenti. Le perle si sgretolarono all’impatto fino a diventare sabbia e il vetro dell’ampolla, similmente alle lampadine che poco prima avevano emanato una luce ultraterrena, si frantumò irreparabilmente.
Solo il legno, ultimo baluardo di ostinazione, rimase intatto.
Ma non fu tutto per il povero Emilio Ischitano. Mentre lo sventurato prendeva atto della tragedia che gli stava capitando, una fitta al cuore, pungente ed elettrica come un fulmine che con violenza si scaglia su una roccia del deserto, lo colpì senza pietà, lasciandolo stordito sul pavimento, l’anima ormai in pezzi come i frammenti della sua lampada.
La mattina seguente un raggio di sole autunnale scaldò il viso del povero Emilio.
Fisicamente si sentiva bene, ma quando aprì gli occhi e si accorse di quello che era accaduto, capí subito che si trattava di un evento irreversibile.
C’è poco da fare, si disse.
Risoluto come al solito, era già arrivato a una conclusione netta, definitiva, inappellabile, che nel giro di poche ore portò dalla teoria all’atto pratico.
Tanto per cominciare, sollevò i frammenti, ormai impossibili da ricomporre, e dopo averli triturati fino a renderli sabbiosi con un martello, getto la sabbia in aria affinché si dissolvesse nel vento.
Dopodiché, venne la parte più difficile. La sua salute, ormai, era appesa a un filo; per giunta, era legata in maniera indissolubile alle sorti della lastra di legno. Da un po’ lo sospettava, ma dopo quella fitta al cuore, ne aveva avuto la conferma definitiva.
Il dolore per lei significava dolore per lui. L’errore di calcolo fu pensare che anche il dolore per lui significasse dolore per lei, ovvero che la morte dell’uomo, avrebbe comportato anche la scomparsa della lastra.
Oltretutto, non poteva permettersi di lasciare la creatura esposta alla precarietà del mondo.
Quello che avevano iniziato insieme, dovevano finirlo insieme. Ciò che era iniziato nel mare doveva finire nel mare.
Prese un grosso cordone, lungo e massiccio, e legò la sua caviglia alla sua amata lastra di legno. Poi, con l’orgoglio di un gladiatore, si incamminò verso lo strapiombo della scogliera, pronto a spiccare il suo ultimo volo d’amore.
In cover:
Claudio Di Carlo, Luce dei miei piedi, 2002, olio su tela